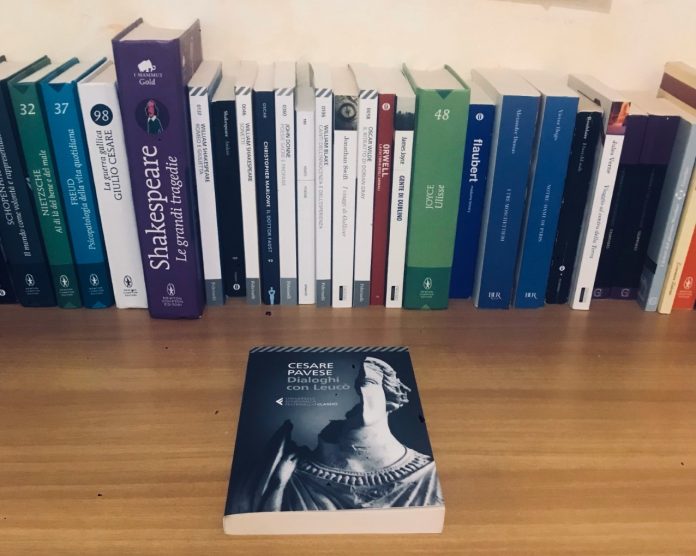Quando ancora non conoscevo Cesare Pavese, mi gironzolavano per la testa i nomi Leucò, luna e falò, casa in collina, ma non avevo la benché minima idea di cosa fossero nello specifico. Mica te lo insegnano a scuola Pavese, te lo devi fare da te. E menomale, aggiungerei!
Ah, “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, ecco l’altra associazione.
“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” mi ripetevo nella mente e rimanevo esterrefatto dalla potenza di quelle parole che trasmettevano d’impatto un senso di dolcezza.
Sì, avete letto bene: dolcezza. Bisognava approfondire!
Con queste premesse ho scelto “Dialoghi conLeucò” perché, inutile negarlo, l’idea del mito ha una marcia in più, un fascino particolare. L’ho fatto a scatola chiusa, senza sapere quanto mito ci fosse realmente dentro. Con alle spalle una discreta conoscenza sull’argomento “Mitologia” e con il timore di dover rispolverare qualche vecchio libro al fine di far tornare alla memoria le vicende ivi narrate.
Ma tutto ciò non è stato necessario, non ce n’era il bisogno perché i dialoghi vanno benissimo da soli senza necessità alcuna di conoscenze pregresse, anzi, fungono da stimolo per approfondimenti!
La scelta dell’autore di non fissare un ordine preciso nella strutturazione dei racconti è uno dei primissimi aspetti caratteristici di questa saggissima penna poiché sottolinea una libertà d’interpretazione, oltre che un chiaro motivo di trasmissione esclusiva del sentimento come fine ultimo di tutto il lavoro, senza altri obiettivi, slegato da preconcetti e da pre-costruzioni.
Sorvoliamo volontariamente l’excursus biografico su Pavese e sul periodo di stesura del libro: è fuor di dubbio che la vita e l’esperienza vadano a braccetto ed influenzino le opere degli autori, è verissimo che il contesto storico abbia la sua assoluta rilevanza, ma è altresì vero che un artista è in grado di esprimere le sue idee al di là dei binari storico temporali in favore dell’unico binario senza tempo, quello delle emozioni. Quindi “limitiamoci” a scoprire e a riflettere su questo profondissimo capolavoro, lasciandolo libero, così com’è per natura.
Capolavoro già nella struttura: “Dialoghi con Leucò” è una raccolta di dialoghi brevi in cui i protagonisti sono i personaggi del mito, cioè divinità, eroi e poeti; Pavese, per loro bocca, riesce a trasmettere la sua visione sull’esistenza: un sottilissimo filo che ondeggia tra il dubbio e l’assenza di risposte, tra il tedio di vita e l’urgenza di vivere.
Pavese si serve di Eros e Tànatos, di Edipo, di Odisseo, si maschera dietro questi personaggi per sprigionare una profondità struggente, lacerante. Nel primo racconto, “La nube”, si avverte quel senso di iniziale smarrimento dell’uomo nel confronto con l’eventuale, e più che mai dubbia, esistenza divina:
Siamo tutti asserviti a una mano più forte
Questo sentimento, però, inizia subito a venire meno nel secondo dialogo, “La chimera”, che si chiude così:
|…| prima ti tolgono ogni forza e poi si sdegnano se tu sarai meno che un uomo. Se vuoi vivere, smetti di vivere…
La forza della parola in Pavese è devastante, specchio di una sofferenza interiore difficilmente esprimibile in versi o frasi e che invece l’autore è riuscito a far venir fuori con profondissima maestria. Ed è proprio la dolcezza di cui sopra che, di dialogo in dialogo, cresce a dismisura fino a colpire al cuore il lettore e lasciarlo così: smascherato, immobile e spaesato.
Prendiamo a testimonianza alcuni passi:
“Esser cieco non è una disgrazia diversa da esser vivo” (da “I ciechi” – dialogo, sublime trovata, tra Tiresia ed Edipo);
“Se non altro ha trovatosestesso morendo” (da “Le cavalle”).
Quel che rende quest’opera un capolavoro è quel continuo pathos, quel sentimento di soffrire la vita che è proprio dell’artista, che è proprio non tanto di chi pensa, ma di chi lo fa profondamente, di chi riflette, di chi è vittima di quella continua incapacità di collocamento nel mondo, di chi ansima a causa di una spasmodica pretesa di risposte conscio di non ottener nulla, ma indomito nella ricerca di un segno, di ritrovarsi, per scorgere, alla fine, un indicibile senso di vuoto:
“E non sai che il selvaggio e il divino cancellano l’uomo?” (da “La belva”).
Uno dei punti più toccanti è il dialogo tra Saffo e Britomarti in “Schiuma d’onda”:
“|…|
– Oh Saffo, onda mortale, non saprai mai cos’è sorridere? –
-Lo sapevo da viva. E ho cercato la morte. –
|…|
-Non hai mai conosciuto donne mortali che vivessero in pace nel desiderio e nel tumulto? –
|…|
-Se non posso esser Saffo, preferisco esser nulla. –
-Dunque accetti il destino? –
-Non l’accetto. Lo sono. Nessuno l’accetta. -”.
Come si è potuto evincere sinora, in Pavese filosofia letteratura e poesia si fondono in un unico insieme.
Il momento, per così dire, più filosofico dell’opera lo troviamo nel dialogo “La madre”, in cui Ermete rivolge a Meleagro questa imprescindibile ed inconfutabile domanda:
“Tu credi che l’uomo, qualunque uomo, abbia mai conosciuto l’altro?”, a prova del fatto che non c’è alcuna ragione valida per le vili e pretenziose supposizioni d’ogni tipo che i meschini uomini lasciano invidiosamente andare sulla vita degli altri.
Tra i tantissimi temi toccati spicca l’impossibilità di comprendere il fine della vita ed il post-mortem.
Nel dialogo “I due”, tra Achille e Patroclo, il giovane avventuriero, con il cuore infiammato per la dipartita che lo aspettava di lì a poco è nel vivo del confronto con l’amato che, sul più bello, tuona così:
Verrà il giorno che saremo cadaveri. Che avremo tappata la bocca con un pugno di terra. E nemmeno sapremo quel che abbiamo veduto.
Lapidario!
Il dialogo prosegue con un velo di ironia da parte dell’autore, quando Achilleafferma che “Solamente gli dèi sanno il destino e vivono”, chiaro riferimento alle tante religioni proclamatrici del nulla in cambio del nulla.
E ancora a tema, nel passo “I fuochi”, due pastori, padre e figlio, dialogano finché il padre non richiama il figlio al lavoro da portare a termine come a voler segnalare l’incapacità di sfuggire al destino, di cambiare il fato, in quanto necessità imposta dalla vita e difficilmente sovvertibile.
“|…|
Noi invece nessuno ci aiuta. Faccia pioggia o sereno, cosa importa agli dèi? Adesso s’accendono i fuochi, e si dice che fa piovere. Che cosa gliene importa ai padroni? Li hai mai visti venire sul campo?”.
Nel racconto “La rupe”, Prometeo dice ad Eracle che “Il vittorioso è sempre un dio” fino a chiudere drasticamente il discorso divino con queste parole, per bocca di Orfeo, nel dialogo “L’inconsolabile”:
“Tutte le volte che s’invoca un dio si conosce la morte. E si scende nell’Ade a strappare qualcosa, a violare un destino. Non si vince la notte, e si perde la luce. Ci si dibatte come ossessi”.
Non c’è nulla da aggiungere, sia concessa soltanto una velocissima riflessione prendendo in prestito la frase di Swift:
“Abbiamo fin troppe religioni per odiarci, ma non abbastanza per amarci l’un l’altro” è più che mai necessaria”.
A ragion veduta ci si può chiedere quale soluzione trovava Pavese dinanzi a questo smarrimento e mi viene da rispondere: “Alcuna, se non quei fugaci momenti di piacere personale che ognuno, appunto, a suo modo, si concede sospendendo lo spazio-tempo”. Per l’appunto:
“Immortale è chi accetta l’istante. Chi non conosce più un domani” (da “L’isola”, dialogo tra Calipso e Odisseo).
Sempre ne “L’inconsolabile” lo scrittore rimarca l’impasse dell’uomo sulla vita difendendo e consolando il povero Orfeo, ormai privato e privo per sempre di Euridice, con un balsamico:
“Eri tanto innamorato che – solo tra gli uomini – hai varcato le porte del nulla. No, non ci credo, Orfeo. Non è colpa tua se il destino ti ha tradito”.
Pavese, da artista eccelso, non nasconde un certo velo di superiorità o, chiamiamola così, diversa visione prospettica, appunto classica e propria degli artisti, e getta delle piccole pillole per i lettori più acuti nel dialogo “La vigna”:
“Gli dèi durano finché durano le cose che li fanno”!
Chiosiamo con uno dei punti più significativi, summa di tutta l’opera, emblema dello smarrimento iniziale, finale ed eterno, risposta a qualsivoglia dubbio, chiave di volta della grandezza di Pavese.
In uno degli ultimi passi, il dialogo “Il mistero”, Demetra chiede a Dioniso:
“Si direbbe che vedi il futuro. Come puoi dirlo?”
E Dioniso replica:
“Basta aver veduto il passato,Deò. Credi a me. Ma ti approvo. Sarà sempre un racconto”.
Qui si comprende che Pavese, fino in fondo, non cercava davvero delle risposte, ma solo constatazioni dello stato delle cose nella vita dell’uomo; da qui si capisce la bellezza e l’eternità dello sfondo del mito come strumento narrativo; da qui si comprende che i tempi passano, ma l’uomo resta e resta nei tempi sempre uguale, tormentato dagli interminabili eterni ed irrisolvibili dubbi sulla vita!
L’uomo mortale,Leucò, non ha che questo d’immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia.
Godiamo, dunque, dell’immortalità di questo stupendo (im)mortale, godiamo di questo suo fantastico ricordo lasciatoci con meravigliosa e gentile dolcezza!
Lorenzo Romano